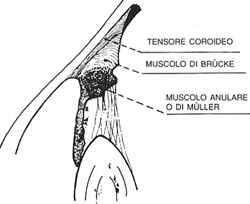Testi
concessi dal Prof. Sergio Villani
OPTOMETRIA
E OFTALMOMETROLOGIA - primo volume
IL
CORPO CILIARE
La parte anteriore della coroide, nel progredire sino all'iride,
passa sulla superficie interna del muscolo ciliare; qui, innalzandosi,
dà origine a tante pliche radiali che assumono la denominazione
di processi ciliari, riccamente vascolarizzati da vasi finissimi
e sostenuti da tessuto stromatico pigmentato. Questo stroma si immette
anche tra le fibre che costituiscono il muscolo ciliare arrivando
a formare, tra il muscolo e la sclera, uno strato molto sottile
e riccamente pigmentato, il quale, essendo un tessuto piuttosto
lasso, in caso di intervento chirurgico, consente di staccare con
facilità il muscolo ciliare dalla sclera. Anche la superficie interna
del corpo ciliare è rivestita da epitelio formato da un doppio strato
di cellule, delle quali, quelle più esterne sono riccamente pigmentate,
mentre le interne non contengono pigmento e sono dette cellule chiare
(fig. 11-24).
Il
corpo ciliare, visto dall'interno (fig. 11-25),
ci
mostra quelle pliche a salienza radiale di cui abbiamo già accennato
e che si chiamano processi ciliari; il loro numero è di circa 70,
la lunghezza 3-4 mm, la larghezza 0,5 mm, la profondità 0,5-1,5
mm. Gli spazi che suddividono i vari processi ciliari si chiamano
vallecole. La parte pianeggiante che va dall'ora serrata
all'inizio delle pliche, si chiama orbicolo ciliare. Poiché i processi
ciliari sono stati suddivisi in una testa, un corpo e una coda,
alle teste di tutti questi processi è stata riservata la denominazione
di corona circolare. Nel
corpo ciliare è contenuto il muscolo ciliare (fig. 11-26 e I 1-27),
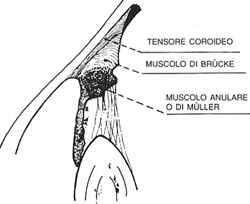 Fig.
11-26
Fig.
11-26
 Fig.
11-27
Fig.
11-27 |
il
quale è costituito da un complesso di fibre liscie, una parte delle
quali è raggiata e viene chiamata muscolo di BRUCKE;
un'altra parte è anulare e prende la denominazione di muscolo di
MULLER, il quale forma un anello corrispondente alla corona
circolare; un'ultima parte, formata da fibre longitudinali, è chiamata
tensore sclerale. La fig. 11-27 mostra tra l'altro, come il muscolo
ciliare sia interposto tra la sclera all'esterno e la proliferazione
coroidale (membrana vasculosa) all'interno. L'innervazione del muscolo
ciliare deriva dal III paio di nervi cranici cioè in modo analogo
a quella dello sfintere dell'iride; la qual cosa spiega anche l'analogo
e simultaneo comportamento di fronte a sostanze cicloplegiche, miotiche
e in molte alterazioni del sistema nervoso. Secondo recenti teorie
sembra convalidata l'analogia tra il muscolo di MULLER e
lo sfintere pupillare, nonché quella tra il muscolo di BRUCKE
e il dilatatore pupillare.
Appare evidente che, secondo questo modo di vedere, il muscolo di
MULLER (innervato dal parasimpatico) sarebbe il vero muscolo
dell'accomodazione, mentre quello di BRUCKE: (innervato dal
simpatico) esercitando un'azione di tensione sulla zonula di ZINN,
verrebbe ad esercitare un'azione di inibizione dell'accomodazione.
Si è anche detto che il muscolo ciliare, invece di essere costituito
da due muscoli antagonisti, possieda una doppia innervazione, simpatica
e parasimpatica, le quali, agendo una da effettrice e l'altra da
inibitrice, in ultima analisi produrrebbero lo stesso effetto.
Ligamento
sospensore o zonula di Zinn (zonula ciliaris)
È praticamente la continuazione della membrana limitante interna
della retina (vedi retina).
La zonula consiste proprio di filamenti che nascono sia dalla limitante
interna all'ora serrata, sia dall'epitelio chiaro dei processi ciliari.
Nel suo complesso, la zonula di ZlNN costituisce un anello appiattito
con sezione a forma di triangolo isoscele; le fibre che formano
i lati maggiori si attaccano anteriormente e posteriormente alla
periferia della capsula del cristallino; lo spazio che si viene
a formare tra le fibre vicine all'equatore del cristallino prende
il nome di CANALE DI PETIT.
L'apice che formano i due lati maggiori, corrisponde alla regione
orbicolare. Il ligamento non è una vera e propria membrana, cosicché
I'umor acqueo filtra attraverso le sue fibre, le quali hanno un
diametro di circa 5 micron.